Bentornate e bentornati su A Cosa Penso Quando Corro?, la newsletter che ha sconfitto i bot che hanno provato a impossessarsi di Substack.
La rituale presentazione: A Cosa Penso Quando Corro? è uno spazio in cui si parla di running, come sport da guardare, come sport da praticare; come fatto sociale, economico, culturale e introspettivo.
E che esce ogni due domeniche alle 10 del mattino.
Per recuperare le puntate precedenti potete consultare l’archivio di ACPQC?
ACPQC? è e sarà sempre gratuita. Chi la scrive fa del suo meglio attingendo dal proprio tempo libero, solo per passione. Il modo migliore per supportarmi è condividendola ai tuoi amici o ai membri del tuo running club o della tua squadra. È semplice, basta schiacciare il bottone qui sotto:
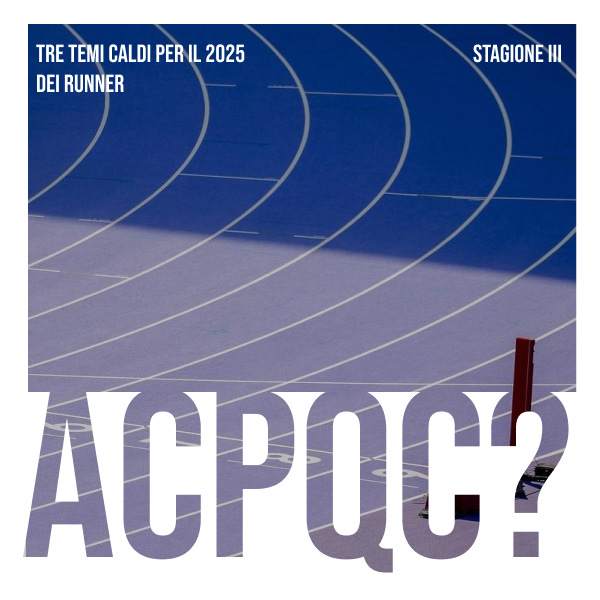
Qui l’indice:
Atleti vs. Influencer
Sostenibilità: tedio od opportunità?
Farsi belli per uscire a correre?
Calendario alla mano, questa è l’ultima puntata di ACPQC? del 2024.
E nell’ultima puntata dell’anno, non vorrete mica leggere l’ennesima lista di regali perfetti per un runner, vero? (Anche perché ormai il tempo è risicato, e sono qui per dirvi l’amara verità: dovevate pensarci prima - e l’e-commerce su cui farete l’acquisto rifiuterà tutti i vostri metodi di pagamento, compreso quello per dilazionare l’importo della transazione in tre comode rate da €7 tra qui e febbraio).
O, ancora, non vorrete mica leggere un altro post lunghissimo su qualche scandaloso caso di sportwashing, greenwashing, socialwashing che vi fa passare la voglia di credere nello spirito del Natale? (Ma che durante il cenone, se buttato là a dovere e con i giusti tempi scenici, vi permetterebbe di innescare lo zio strambo che passa troppo tempo su X, con l’effetto che non sarete mai più invitati a questi ritrovi. A voi la scelta).
No, in questa puntata voglio sbilanciarmi.
Il 2024 è stato un anno benedetto per il running. I dati ufficiali dell’industria usciranno solo tra qualche mese, ma la crescita del settore sembra pienamente confermata - le fonti parlavano di una crescita annua media del 5% tra il 2020 e il 2024, e l’increase tra il 2023 e l’anno che va a chiudersi parrebbe avvallare il dato. La percentuale di iscrizioni alle gare è stata, di nuovo, in aumento - anche se ancora lontana dai livelli del 2019 - e i dati sul mix degli atleti presenti ha fatto registrare un pur lieve incremento di partecipazione per la fascia 18-29.
A livello sportivo, le Major Marathons sono state il palcoscenico per prove storiche - a partire dallo storico record nella maratona femminile di Ruth Chepngetich. E poi le Olimpiadi: una passerella prestigiosissima per l’atletica, e un’occasione che il movimento ha onorato alla grande (con tantissime prove di assoluto pregio sportivo). Per l’Italia, non possiamo non menzionare l’acuto dell’Europeo di Roma, con le notti magiche dell’Olimpico, una Nazione che riscopre l’atletica - attraverso le conferme dello share televisivo - e il lancio di tante e tanti bravi atleti che possiamo assurgere a modelli sportivi e umani positivi.
Al termine di un anno molto positivo per l’industria del running cosa possiamo aspettarci nel 2025? Ho racchiuso in tre punti quelli che secondo me potrebbero essere alcuni trend, o temi caldi per i prossimi dodici mesi.
Intanto, se vi va, lasciatemi un commento: qual è stata la vostra puntata preferita di ACPQC? per il 2024? (Se non vi va di lasciarmi un commento, scrivetemelo via mail!)
Atleti vs. Influencer
Ultimamente, sembra che io e Giovanni di
abbiamo una particolare telepatia. Io comincio ad impostare un capitolo sul delicato rapporto tra atleti e running influencer e lui fa uscire un’intera puntata della sua newsletter sulla scelta degli atleti di college - soprattutto USA, ma il fenomeno è in espansione anche in Europa (con il canonico ritardo di un anno o due) - di anteporre la content creation alle proprie mire sportive.Giovanni racconta come il crollo di una storica regola che impediva agli atleti collegiali di trarre profitto attraverso la propria immagine da qualsiasi tipo di partnership commerciale stia generando un effetto che da un lato permette alle superstar dei college (e il sistema NCAA ne sforna costantemente di nuove, gli appassionati ricorderanno l’hype attorno ai vari Zion Williamson, o Chet Holmgren, per dirne due particolarmente recenti) di costruirsi fonti di guadagno secondarie molto interessanti (molto interessanti!); dall’altro garantisce ad atleti meno sportivamente dotati (ma non privi di creatività) di costruirsi una figura pubblica diversa.
Il problema sorge negli interstizi di questi risvolti positivi: quando prospetti dal grande potenziale sportivo percepiscono che attraverso la content creation possono fare non tanto più soldi (anche se in molti casi, vista la selettività estrema, con la vita da influencer guadagnerebbero effettivamente di più che da un ipotetico futuro in qualche lega minore), ma soldi più facili.
Dalla puntata di Fubolitix Sport e social media, la rivoluzione silente di venerdì 20 dicembre 2024:
Questa opportunità ha trasformato molti [atleti] in influencer, un ruolo che - non serve nemmeno dirlo - ha contenuti diversi rispetto a quelli dello sportivo.
Al centro di tutto sta il concetto di contenuto, che è intrattenimento, contrapposto a quello di notizia e nella fattispecie di notizia sportiva, che ha una portata proporzionale al valore tecnico di quanto esprime.
Per capirci: la finale di Champions League vale più della finale playoff di B… fino al giorno in cui il campionato inferiore non genera audiences superiori, che tuttavia difficilmente possono essere tali per motivi squisitamente tecnici.
Ecco, nell’universo del running sta succedendo qualcosa di simile, seppur con modalità e presupposti diversi: e con conseguenze che, a differenza di quanto non accada per il sistema collegiale americano (o almeno gli sport più popolari del circuito), rischiano di minare l’essenza stessa di quella che Giovanni definisce «notizia sportiva». Perché se la condizione necessaria per cui un brand vada alla ricerca di un giovane nel circuito NCAA è che questi sia quantomeno un vero atleta (riconosciuto come tale, all’interno di un team seguito da coach e un entourage di professionisti), per il running questo concetto decade quasi completamente, e la sovrapposizione tra chi fa soldi per i propri contenuti legati alla corsa e chi è effettivamente un professionista è esigua.
Di questo particolare aspetto legato al running ha parlato approfonditamente Matt Trappe in un intero episodio di A matter of brand (che ho letto un po’ di tempo fa, quando ancora pubblico, e che ora è sotto paywall). Per fotografare la portata del fenomeno, Trappe parte dalla lista delle 10 personalità più seguite durante la Maratona di New York - grazie al sistema che permette il tracking in tempo reale dei podisti in gara. 7 su 10 erano influencers. Andando a memoria - non ho ritrovato il tweet a cui Trappe faceva riferimento - il primo nella lista era Casey Neistat (newyorker e youtuber di culto); gli altri influencers hanno un raggio d’azione circoscritto alla sfera USA (sono abbastanza sicuro che tra di loro non ci fosse Matt Choi, squalificato per essersi fatto riprendere durante tutta la gara da una troupe di cameramen che lo hanno seguito in E-Bike). Tra gli atleti professionisti, figuravano la defending champion Hellen Obiri e l’eroe di casa Conner Mantz, sesto qualificato e primo americano.
Agli amatori frega qualcosa dei professionisti?
La conseguenza di questo sbilanciamento nell’interesse verso i non-élite è che, con l’eccezione degli atleti top, le retribuzioni (già esigue) messe in campo per i professionisti sono ulteriormente assottigliate dalla concorrenza dei creatori di contenuti. E metriche di marketing alla mano, il confronto non solo è impietoso, ma fa apparire la scelta praticamente ovvia per i brand. Il perché è abbastanza semplice. A un livello più “alto” (diciamo così), il pubblico dei podisti amatoriali è meno interessato alle imprese atletiche dei professionisti di quanto non lo sia della quotidianità di runner assolutamente mediocri (come lo siamo tutti noi). È più facile rispecchiarsi nell’influencer fulminato sulla via di Damasco che ha deciso di prendere in mano la propria vita e correre la propria prima maratona partendo da zero e commettendo i classici errori; è più facile riconoscersi in una persona normalissima che - proprio come me e te! - a un certo punto si è follemente innamorata della corsa e che con qualche video-consiglio della durata di 30 secondi riesce ad attivare quello Spirito Santo che è il confirmation bias.
A un livello più basso, accade quello che inquina tutti i settori: titoli demenziali e contenuti di scarsissimo valore aggiunto - ma di grande attrattiva e alto potenziale di viralità (cose tipo «corro una maratona senza allenamento») - abbagliano marketing manager poco lungimiranti e ingrassano le tasche di buoni comunicatori che nulla hanno a che spartire con l’essenza dello sport.
Per un professionista, costruirsi non dirò una fortuna, ma la base per vivere è più dura di quanto non lo sia per un influencer. Tutto considerato, per molti il gioco non vale la candela.
Un trend auspicabile per il 2025 è un maggior coinvolgimento dei brand e dei grandi eventi di massa nel rivedere il modo in cui i professionisti sono inseriti in un mix comunicativo efficace. Non tutti gli atleti di punta sanno o hanno voglia di registrare contenuti (è nel loro diritto non saper fare queste cose), né possono permettersi di delegare a qualche risorsa esterna: ma i dipartimenti marketing dei brand hanno queste capacità. Perché non sottoscrivere contratti che prevedano la messa a disposizione di professionisti della comunicazione per una collaborazione mutua e profittevole sia per il personal branding dell’atleta che per una maggiore credibilità delle aziende?
Quando queste collaborazioni vanno in porto, nascono spesso contenuti efficaci ed emozionanti, che dànno valore sia al brand che all’atleta - che ne guadagna in popolarità ma anche in un posizionamento virtuoso nella mente dell’appassionato, attraverso una comunicazione di sé che con mezzi propri sarebbe stata oggettivamente più difficile da raggiungere. On (che non sponsorizza in alcun modo questa puntata) insegna:
Sostenibilità: tedio od opportunità?
Chi segue ACPQC? da un po’ ormai sa quanto il tema della sostenibilità applicato al running sia uno dei miei pallini. Non tanto per bacchettare e/o fare la classifica di chi è più o meno sostenibile (mi sono reso conto di aver commesso, anche di recente, una serie di scelte abbastanza discutibili), quanto per accrescere consapevolezza e fare informazione.
Quello che mi tocca constatare è una desolante penuria di voci all’interno del Mondo del running - che si tratti di giornalismo, content creation o influencer marketing - che facciano da cassa di risonanza a preoccupazioni che in altri settori hanno portato a discussioni mature sul tema.
di Runlovers in un commento al primo (embrionale e parziale) pezzo che ho scritto nel 2024 sul tema era stato abbastanza categorico:Su Runlovers cerchiamo da ormai 3 anni di sensibilizzare con articoli singoli ma anche con cicli interi (io ne ho curati diversi) sulla vita più rispettosa dell’ambiente, sull’alimentazione, sui consigli pratici. Posso essere brutale? Non gliene frega niente a nessuno o comunque a pochissimi. Articoli del genere sono scansati come se fossero uccelli del malaugurio o al più come contenessero cose che “È così, cosa ci vuoi fare”. Sono sempre ottimista ma su questo argomento non lo sono molto, ahimè.
«Uccelli del malaugurio». Mi piace questa espressione, perché è calzante, e quando si scrive cosa si fa se non cercare di essere calzanti? Di questo sentirsi cornacchie ciancianti da guardare con diffidenza e una punta di ironia, del tipo «ma che esagerati, allora chiudetevi in casa e smettete di vivere» ha scritto anche la giornalista statunitense Zoe Rom in un guest post per
di Matt Walsh, dal titolo Running media has an Environmental Problem. L’espressione che Rom - che di clima scrive sul New York Times ed è autrice di un libro intitolato Become a sustainable runner - utilizza è parimenti calzante:Writing about climate change in running media sort of feels like walking into a cocktail party just to remind everyone that last year was the hottest year on record, 2.12 degrees Fahrenheit (1.18 degrees Celsius) above the 20th-century average (true!).
Scrivere di cambiamento climatico nei running media è come entrare in un cocktail party per ricordare a tutti che l’anno scorso è stato il più caldo mai registrato, 2.12 gradi Fahrenheit (1.18 Celsius) sopra la media del 20esimo secolo (vero!).
Il passaggio successivo è chiedersi: perché è così? Com’è possibile che quando dobbiamo comprare un paio di scarpe abbiamo la capacità di dedicare ore e ore a video recensioni, articoli di comparazione, blog, post su Reddit, ma non riusciamo a spendere un singolo minuto a valutare materiali, impatto della produzione, scelte di sostenibilità delle aziende produttrici?
Una risposta possibile che mi sono dato è che all’interno di un Mondo complicato, indecifrabile - dove il male dilaga e ci ha abituati al fatto che il brutto non solo è giusto, ma in fondo è anche accettabile perché le cose vanno così - l’appartenenza a una categoria umana come quella dei runner funga come una sorta di meccanismo di difesa - cosa che, a vari livelli, fanno tutti i passatempi. È la nostra fuga in uno spazio sacro in cui per mezz’ora, un’ora al giorno i mali del Mondo non ci toccano. Parlare di qualche cosa di potenzialmente minatorio per l’intero movimento è un comportamento da ostracizzare e da allontanare come meccanismo di autodifesa. Che se ne parli: purché fuori dai confini del nostro orticello zen. Non qui, non ora. C’è un’altra corsa da fare, e mi serve un nuovo paio di scarpe.
E allora che cosa fare? La risposta è difficile: i media di settore sanno che i contenuti di questo tipo non portano click e a meno che la flash news non fornisca un gancio per un post con cui ripulirsi la coscienza (presente la Giornata mondiale della Terra) è difficile che trattazioni articolate trovino spazio. Và reinventato un modo diverso di parlare di running e ambiente. Scrive Zoe Rom:
It takes a lot of imagination to transform stories of ecosystem degradation, mass extinction, climate refugees, and ocean dead zones into something that the average person wants to read - when a flashy YouTube video or comforting listicle is also at their fingertips.
Ci vuole un sacco di inventiva per trasformare storie di degradazione degli ecosistemi, estinzioni di massa, rifugiati climatici e zone morte dell’oceano in qualcosa che le persone comuni abbiano voglia di leggere - mentre un accattivante video YouTube è a portata di un click.
Nel quadro di un contesto difficilissimo e in piena esplosione, sempre Zoe Rom:
We need stories that challenge, excite and energize our community to take big and scary action. We need to get comfortable getting uncomfortable (something we seem to be very good at IRL, and very bad at online) and pushing ourselves to engage in new ways. We need to get political, stop endorsing runaway consumerism, and step outside our identity as trail runners and engage as citizens of a shared world.
Abbiamo bisogno di storie che sfidino, stimolino e diano alla nostra comunità l’energia per fare azioni forti. Abbiamo bisogno di abituarci al discomfort (cosa che siamo molto bravi a fare nella vita reale, molto meno online) e spingerci a interagire in nuovi modi. Dobbiamo diventare politici, smetterla di supportare il consumismo mordi e fuggi, e uscire dalla nostra nicchia di (trail) runner per interagire come cittadini di un mondo che è di tutti.
Che il 2025 possa essere l’anno in cui più gioranlisti, creator, chiamatelicomevipare comincino a includere questo tipo di discorso nei propri lavori?
Un grazie di cuore a Matt Walsh di
che è stato disponibilissimo nel permettermi di postare queste traduzioni di mio pugno dalla sua newsletter su ACPQC? Vi consiglio la lettura di un suo interessante pezzo che è stato l’apripista per il commento di Zoe Rom: Running Media’s Environmental Blind Spot.Farsi belli per uscire a correre?
How marathon became fashion shows. È un titolo che quest’anno è rimbalzato dal Financial Times a The Business of Fashion - con alcune declinazioni sul tema, per la verità. Ed è sbarcato, infine, sulla newsletter di Lee Glandorf,
, nella puntata del 4 novembre 2024 Running’s Fashion Renaissance.Quale evento può offrire il destro per un titolo simile se non la gara per eccellenza, la Maratona di New York? Qui la moda e lo sportswear si incontrano in un connubio che ha già stregato lo sport in passato.
Because that’s where we’re at in running – especially in New York – right now. A fever pitch. The momentum coming out of Covid has been supercharged by the emergence of run club Tiktok, Gen Z’s penchant for using the marathon as a panacea for their quarter-life crisis, the rise of Strava, and non-endemic brands’ desires to capitalize on the high-earning, high-spending running consumer.
Questo è il qui e ora del running - specialmente a New York. Una febbre di entusiasmo. L’inerzia dell’uscita dal Covid è stata caricata dall’emergere dei run club su TikTok, dal debole della Gen Z per le Maratone come panacea per la loro crisi del quarto di secolo, dalla crescita di Strava e dall desiderio di brand non-endemici di capitalizzare sui runner, consumatori alto-spendenti.
Fino a qualche anno fa, per i runner non c’era nulla di importante nell’apparire. Bastavano un paio di pantaloncini, un paio di scarpe e la vecchia maglietta in dotazione dalla squadra di calcio - che con il tempo sarebbe stata sostituita dalle t-shirt in plastica, orrende, messe in dotazione dagli organizzatori di gare.
Era semplicemente un Mondo diverso. La ruota è evidentemente in moto (prestando un po’ di attenzione agli outfit sfoggiati nelle zone più sature di runner, specialmente a Milano, è impossibile non notarlo), ma manca ancora qualcosa all’esplosione della bolla, almeno in Italia - siamo sempre un pelo indietro rispetto a questi fenomeni che si propagano da oltre oceano. Da un lato, il target medio italiano resta più anziano - e comunque legato all’acquisto di footwear e accessori meno appariscenti e più funzionali: in una parola, più nerd (anche questo un termine mutuato dalla newsletter che ho appena citato). Dall’altro, come Glandorf conferma, l’esplosione di una nuova coscienza fashion sarebbe stata impossibile senza la mediazione dei running club e delle run crew. Questo è il quid decisivo che manca all’Italia, pur con i soliti centri (Milano e Torino i più importanti) a fare da apri pista.
Se proprio vogliamo abbozzare un parallelo, in Italia la crasi tra età del target e aggregazione dei podisti è sublimata nel concetto di società sportiva (o squadra), che sì, in alcuni casi fa da collante sociale (e alle volte diventa un vero e proprio running club), ma funge più che altro da abilitatore burocratico che consente ai runner di ricevere le visite medico sportive a prezzi agevolati e di iscriversi alle gare (sempre a prezzi agevolati). Va da sé che il gusto profuso dai responsabili delle società nel creare le divise sociali è… quello che è. Senza nulla togliere a eventuali esempi virtuosi, che sicuramente esisteranno (segnalatemeli nei commenti).
Collateralmente, ci sono una serie di domande a cui bisogna rispondere per provare a fare una previsione sui tempi e le modalità con cui gli ammiccamenti della fashion industry attecchiranno sui runner italiani.
Le infiltrazioni di trend in diffusione centrifuga dagli USA all’Europa da quali figure pubbliche sono mediate? A quale pubblico si rivolgono queste figure? C’è un effettivo supporto dei brand verso azioni spontanee proposte dai creators europei ispirati da controparti importantissime in Nord America ma sconosciute in Europa? Quanta è la predisposizione di questi creators a fare sistema per raggiungere fasce più larghe di pubblico, con l’effetto collaterale di una maggiore diffusione delle mode? Come si configura il supporto dei brand alle running crew? Quanto spazio di manovra hanno i membri di queste running crew nel definire la propria identità?
Ovviamente è solo questione di tempo - e mi arrischio a dire che non manchi poi più di tanto. Sarà un fisiologico ricambio nel mix dei fruitori degli eventi che contribuirà alla diffusione degli ultimi trend? O sarà il boost nella socialità dei corridori per mezzo dei running club - impossibili senza la mediazione dei social network - a fare da catalizzatore per l’infiltrazione delle mode?
Un po’ e un po’. Come fenomeno legato alla nostra passione, abbiamo il dovere di osservarlo. Con una domanda: dove sta il confine tra moda, cultura e acume da parte dei designer nel cogliere lo spirito dei tempi e l’ingerenza da parte dei brand per forzare i comportamenti di acquisto di un’intera categoria di consumatori? Prego, tornare al punto numero due.
Un anno vola: grazie di cuore!
Mentre vi scrivo, la dashboard di Substack segnala che siamo 428. L’1 gennaio 2024, e cioè approssimativamente 355 giorni fa eravamo 145: questo vuol dire che in dodici mesi ACPQC? è cresciuta di circa il 195%, mantenendo un tasso di apertura medio del 45%. È un numero incredibile, sul serio.
Alla fine della fiera, i numeri dovrebbero interessare il giusto: nondimeno, le metriche sono delle indicazioni che aiutano a confermare la bontà di questo progetto e di tutto l’impegno che, settimana dopo settimana, metto per portare contenuti qualitativi in questo spazio.
Mentre rinnovo l’invito a commentare la vostra puntata preferita del 2024 (o se preferite a scrivermela via mail), vi ringrazio di nuovo dal profondo del cuore per aver letto, apprezzato, smontato e interagito
🏃🏻♂️ Ti è piaciuta A cosa penso quando corro? Come puoi sostenere il progetto
Se non lo hai ancora fatto, iscriviti alla Newsletter: ogni iscrizione è importante, mi motiva a credere in questo progetto.
Iscriviti ad A cosa penso quando corro?
Condividi A cosa penso quando corro? con amici, parenti, contatti, su Instagram, Twitter, Facebook, in un balletto su TikTok. Vedi tu!
Il Podcast Storie di Corsa: lo ascolti qui
Anche un like o un commento alla puntata sono utili!
Il mio profilo Instagram: @ban.zo_
Il mio profilo Strava: Lorenzo Bandini
Se questa puntata ti è piaciuta e ti va di sostenere questo progetto, sostieni A cosa penso quando corro? letteralmente al prezzo di un caffè al bar.








A beneficio di tutti i lettori di commenti: sul tema divise fighe segnalo il lavoro di Gente Fuori Strada con WildTee e Alessandro Locatelli nel 2020 e quello di Runaway ASD con Diadora nel 2024. Secondo me in entrambi i casi lavori bellissimi, molto diversi ma credo perchè diverse le caratteristiche delle due associazioni e degni di citazione proprio perchè in grado di trasferire sulla divisa i "valori" della squadra.
Mi vengono in mente un paio di riflessioni sul primo punto. La prima in realtà, più che una riflessione, è un parallelismo: pro player vs content creator nell’ambito del gaming. Basta semplicemente confrontare i dati degli stream su Twitch dell’uno e dell’altro per capire chi ha maggiore risonanza, quello bravo a giocare o quello bravo a intrattenere. Tra l’altro, trattandosi di un campo in cui i valori cambiano molto in fretta (tra i 16 e i 18 anni già c’è grossa differenza per i tempi di reazione, se pensiamo agli sparatutto FPS tipo Valorant o Counter Strike), è molto comune che ex pro player decidano di passare dall’altro lato, abbandonando il competitivo per passare all’intrattenimento.
La seconda riflessione è applicabile sia all’atleta professionista vs atleta amatore content creator, sia all’esempio più su: siamo sicuri che il professionista (runner, gamer, quale che sia) sia necessariamente interessato a sponsorizzare così tanto la propria immagine? Mi viene da pensare, sempre ad esempio, a come viene generalmente concepita la corsa, da un punto di vista culturale, da parte di Kenioti ed Etiopi; e infatti la fetta grossa degli influencer sta - anche in questo campo, come sempre - negli Stati Uniti (per questioni statistico-numeriche, sì, ma per me anche culturali): gli USA, patria del capitalismo per antonomasia, sono terreno fertile per una concezione della propria immagine destinata alla diffusione, alla “vendita” della stessa. Non ho dati a supportarmi, ma a sensazione, tornando al mio parallelismo iniziale, succede molto più spesso che streamer statunitensi passino dal competitivo all’intrattenimento, rispetto a streamer non statunitensi che invece sono meno inclini a snaturarsi (o reinventarsi, chiamiamolo come ci pare).
Comunque, al di là della questione “percettiva” degli Stati Uniti, il quesito resta: è davvero necessario (e, se sì, a cosa per noi che siamo il pubblico?) che quel top 1% di atleti professionisti investa sulla diffusione della propria immagine?