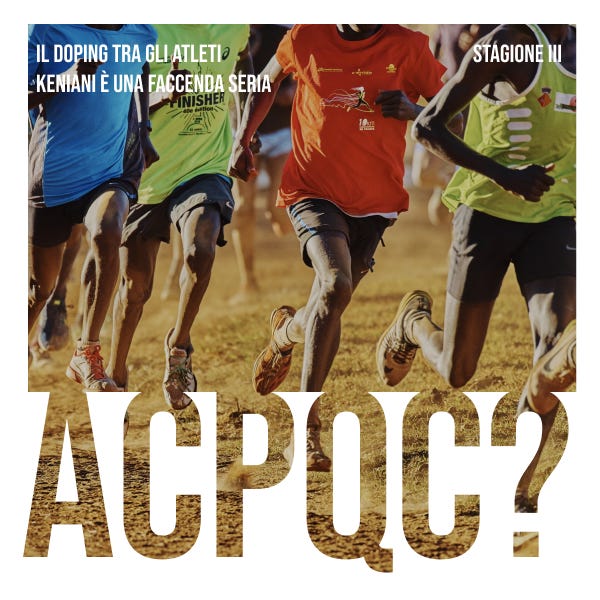Il doping tra gli atleti keniani è una faccenda seria
Dopo la grande festa e il plauso degli appassionati, il recente World Record nella Maratona femminile di Ruth Chepngetich ha riaperto gli occhi del Mondo su una questione spinosa
Buongiorno a tutte e tutti!
Oggi è la prima vera puntata della nuova formula ridotta di ACPQC! Vi sono mancato domenica scorsa?
Intanto, come sempre, la rituale presentazione: A Cosa Penso Quando Corro? è uno spazio in cui si parla di running, come sport da guardare, come sport da praticare; come fatto sociale, economico, culturale e introspettivo.
E che esce ogni due domeniche alle 10 del mattino.
Per recuperare le puntate precedenti potete consultare l’archivio di ACPQC?
Fast Forward: il record del Mondo di Ruth Chepngetich
Domenica 13 ottobre 2024, dopo aver corso e vinto la Maratona di Chicago, Ruth Chepngetich, atleta keniana di 30 anni, si trova con un microfono in mano in una enorme sala stampa. Nessun tavolo, nessuna rappresentanza di bottigliette d’acqua alternate a bevande isotoniche alternate a energy drink, nessun cartoncino su cui leggere il suo nome. È seduta: al suo fianco c’è un moderatore, ritto dietro a un podio rivestito di un pannello di plastica ciano, lo stesso colore del fondale, percorso da una griglia di loghi bianchi. Il setup dell’intervista contribuisce a rimpicciolire le dimensioni della figura già minuta di Ruth Chepngetich (è 1.65 per neanche 50 chili); senza la protezione di un tavolo - o comunque di un qualcosa di fisico tra lei e la sala - è più esposta: in qualche modo sembra vulnerabile.
Le domande dei giornalisti girano tutte attorno a un singolo tema: che non è la vittoria della gara. Ruth Chepngetich non ha solo vinto una Major Marathon (che per altro aveva già vinto altre due volte, nel 2021 e nel 2022), non ha solo dominato la gara femminile dall’inizio alla fine. Ha conquistato il Record del Mondo nella Maratona Femminile con un margine di quasi due minuti sul precedente primato di Tigst Assefa, e lo ha fatto con un tempo finale di 2.09.56, inferiore alle 2 ore e 10 minuti: un limite che nessuno, ma proprio nessuno si sarebbe aspettato di veder valicato in tempi brevi. Per capire quanto il risultato sia eccezionale, il record di Ruth Chepngetich è equiparato a una prova da 1.59.35 secondi per la Maratona Maschile (cinque secondi in meno del tempo di Kipchoge nella Ineos 1.59 Challenge, la prova non ufficiale con cui Re Eliud aveva abbattuto il muro delle due ore). La magnificenza del record polarizza l’interesse della sala stampa.
Non c’è spazio per parlare in maniera estensiva di questa gara, né di che cosa significhi il superamento del limite delle 2 ore e 10 minuti in una prova femminile: per chi volesse approfondire, ho estensivamente parlato della performance in questo pezzo uscito durante la scorsa settimana su Ultimo Uomo. Si legge qui.
La composizione di ogni domanda segue un formulario più o meno fisso: complimenti, elogi, di nuovo complimenti; poi la domanda. Le risposte sono concise. Ruth Chepngetich parla un inglese discreto, con una marcata inflessione. Ribatte con sicurezza a tutte le domande su allenamento, preparazione, sensazioni in gara, sul suo sogno di mettere le mani sul World Record, senza mai avventurarsi in argomentazioni complesse - una dialettica sobria, che aderisce perfettamente al personaggio.
A circa metà conferenza prende la parola Robert Johnson, giornalista di LetsRun.com.
Ruth, purtroppo in anni recenti c’è stato un numero altissimo di atleti positivi al doping in Kenya. Cosa avresti da dire a qualcuno che dicesse «è troppo bello per essere vero, ho dei dubbi sulla cosa»?
Chepngetich sembra fare finta di non aver capito, o sentito bene la domanda: la risposta è vaga «non lo so, non ne ho idea». Johnson raccoglie la perplessità negli occhi dell’atleta. Più che incalzarla, sembra parafrasare, semplificare, distillare la prima versione della domanda:
Sai, alcune persone potrebbero pensare che questo tempo è troppo veloce e tu ti stai dopando. Cosa diresti a chi lo pensa?
Seconda risposta di Chepngetich: «sai, le persone devono per forza parlare… le persone devono per forza parlare, quindi non lo so».
Né mr. Johnson, né la redazione di Letsrun, né Ruth Chepngetich si sono resi immediatamente conto dell’effetto che questa domanda (e la risposta) avrebbero scaturito. Il tono inquisitorio non è andato giù alla Athletics Kenya, che non più tardi di mercoledì 16 ottobre ha rilasciato un comunicato dove difende la propria atleta dalle illazioni a cui è stata sottoposta in conferenza stampa. Il caso è arrivato nientemeno che all’Assemblea Nazionale del Kenya: in un’interrogazione del 16 ottobre, la deputata Gladys Boss Shollei ha chiesto una pubblica scusa di Johnson e di tutta la redazione di Letsrun per la domanda «poco professionale e irrispettosa» (l’intera vicenda è seguita proprio da Letsrun in questo pezzo del 18 ottobre).
La mia prima reazione di pancia è stata: «ma vedi tu se queste sono domande da fare a un’atleta che ha appena fatto il record del Mondo con un risultato storico». Seriamente: perché a lei sì e a Kiptum, lo scorso anno, no? Perché a lei sì e a Tigst Assefa no? Non mi andava giù. Sarò un ingenuo, sarò un illuso, ma il peggio non mi è passato per l’anticamera del cervello. I piccoli scricchiolii di questa risposta tautologica (roba da calciatori interrogati sul loro futuro) li ho fatti passare per un segno dell’indole poco chiassosa di un’atleta riservata né più né meno di tanti e tante podisti. O, ancora, a riprova del fatto che per interviste di questo tipo possa sempre essere utile un traduttore, per dare la possibilità all’intervistato di difendersi (o attaccare) con un arsenale molto più sofisticato di armi linguistiche.
Eppure, frugando con malizia negli spazi lasciati aperti dai non detti della risposta c’è qualcosa che arpeggia come un tritono dissonante anche nella testa di un ingenuo come me. Non si tratta di accusare un’atleta di aver fatto uso di sostanze, cosa che mi guardo bene dal fare, almeno fino al momento in cui dovessero malauguratamente saltare fuori prove che inchiodino le parti in causa alle proprie responsabilità.
Si tratta di cercare di comprendere. Perché il Mondo del Running si è spaccato attorno a questo record? Perché la risposta di Chepngetich alla domanda di Johnson ha fatto alzare più di qualche sopracciglio?
Le ragioni di chi ha sollevato il dubbio sulla pulizia di Chepngetich sono riconducibili a due filoni fondamentali. Il primo è performativo. Non si mette in discussione la prova in termini assoluti (presto o tardi sarebbe comunque arrivata qualcuna in grado di correre in tali tempi), ma di relativizzarla al trascorso dell’atleta. E così alcuni si sono chiesti: come può un’(ottima) maratoneta di lungo corso, con un consistente numero di gare corse sub 2.20 e un personale di 2.14.18 ridurre in una sola volta non di uno, non di due, ma di oltre quattro minuti il proprio personal best? Per dare un riferimento, quando Kelvin Kiptum ha fatto il record maschile nel 2023 (sullo stesso percorso, a Chicago) era alla sua terza gara su tre in sub 2.02, e aveva migliorato il proprio personale di soli 50 secondi: per quanto sia stata comunque una prova in qualche modo trascendentale (e 50 secondi siano pur sempre un’eternità a questi livelli) nel suo caso una prestazione monstre era più facilmente pronosticabile. Sono solo le supershoes? È solo l’aiuto di due pacer uomini che l’hanno scortata dall’inizio alla fine? Basta un miglioramento dell’integrazione dei carboidrati, come affermato dal manager di Chepngetich Federico Rosa (figura su cui torniamo tra poco)?
Il secondo filone di critiche è laterale alla performance, e coglie Ruth Chepngetich in quello che nel pezzo per UU ho definito come “fuoco incrociato”.
Parliamo di un’atleta proveniente da un Paese, il Kenya, alle prese con un decennale scandalo doping. E non si parla di uno o due atleti: al momento la federazione conta 106 atleti bannati dall’Athletics Integrity Unit per l’uso di sostanze illecite. I dati storici parlano di oltre 200 atleti sospesi o sotto processo.
Parte I. Il Kenya e il doping tra i runner di lunga distanza: una breve storia
La storia del rapporto degli atleti keniani con il doping è lunga, travagliata e complessa, e va oltre l’idea di vittoria e di sconfitta.
Sebbene il problema si perda lontano nel tempo, l’anno in cui il Paese si ritrova nell’occhio del ciclone è il 2016: in coincidenza con le Olimpiadi di Rio. Un aumento sconsiderato di segnalazioni mette il Kenya sotto la strettissima osservazione della WADA, la World Anti Doping Agency. Mentre alcuni nomi di altissimo profilo stavano già cominciando a cadere - nel 2014 viene incastrata e sospesa per due anni Rita Jeptoo, tre volte vincitrice della Maratona di Boston e due volte della Maratona di Chicago (due titoli le verranno revocati, e la condanna sarà poi estesa a quattro anni) - comincia a diffondersi la voce di una clamorosa sospensione internazionale della squadra keniana per le severe lacune nel sistema di monitoraggio interno degli atleti, che non rispetta le linee guida internazionale predisposte dall’Agenzia Anti Doping. Tra l’altro, indovinate un po’ chi è il manager di Rita Jeptoo? Proprio quel Federico Rosa di cui parlavamo poco fa, oggi manager di Ruth Chepngetich. Per altro, Rosa avrebbe confermato che Jeptoo faceva uso di sostanze, senza però rivelare la sostanza incriminata - di fatto, mentre esprime vicinanza alla sua atleta, Rosa tenta di scagionare il management team.
Alla sospensione di Rita Jeptoo fanno immediatamente seguito le parole di Wesley Korir, vincitore della Maratona di Boston 2012 e politico keniano eletto al parlamento nel 2013 (la sua parabola è raccontata in un pluripremiato documentario disponibile su YouTube, Transcend). Attorno al clamore suscitato dalla questione Jeptoo, il campione ha lamentato il lassismo degli organi di controllo, a partire dalla Athletics Kenya, e ha subito puntato il dito contro la rete criminale di medici dello sport che alimenta il sistema, facilitando l’accesso degli atleti alle sostanze dopanti. Inoltre, anticipando i tempi di una decina d’anni Korir già nel 2014 chiedeva alla WADA l’apertura di un laboratorio per test estensivi in loco, e quindi nel cuore della Rift Valley.
Nel febbraio del 2016, il Kenya finisce nella Categoria A di monitoraggio della WADA, la più stringente: gli atleti e le atlete sono sottoposti a un numero sempre maggiore di controlli, che incastrano un numero sempre maggiore di atleti e atlete. Le dimensioni dello scandalo portano il governo del Kenya allo scioglimento del Comitato Olimpico Keniano - la questione doping è solo una parte del pout pourri di corruzione e mismanagement che pervadono l’organizzazione (la spedizione di Rio 2016 è un pasticcio, come testimoniato dagli atleti esasperati in tutte le fasi della loro permanenza brasiliana). Contemporaneamente, sempre nel 2016 (sarebbe più corretto dire solo nel 2016) viene formato l’ADAK, l’Anti Doping Agency of Kenya, un organismo interno che da un lato dovrebbe garantire una maggiore aderenza alle misure imposte dalla WADA, dall’altro dovrebbe favorire una più capillare educazione degli atleti circa i rischi del doping sulla salute.
Mentre il Kenya prova faticosamente a reintegrare il proprio status agli occhi del Mondo, nuovi casi e nuove sospensioni emergono a cadenza quasi mensile. Uno dei tonfi più clamorosi è quello di Jemim Sumgong, medaglia d’oro olimpica nella Maratona di Rio 2016 (prima donna keniana a vincere un oro nella Maratona), sospesa per otto anni (con pena aggravata per non-collaborazione con la IAAF durante le investigazioni) in seguito a un test dell’aprile 2017. Poi è stato il turno di Titus Ekiru, campione nella Maratona di Milano con un tempo di 2.02.57 (risultato revocato, che ancora oggi lo avrebbe mantenuto nella speciale lista dei dieci maratoneti più veloci di sempre). Tra gli ultimi clamorosi casi c’è quello di Rhonex Kipruto, detentore del record dei 10 chilometri su strada e vincitore della Mezza Maratona di New York nel 2022: è stato condannato a un ban di 6 anni, con revoca di tutti i titoli dal 2018 ad oggi (compreso un bronzo mondiale nei 10,000 metri).
Nel 2022, dopo una nuova impennata di sospensioni in seguito alla pandemia (25 sanzioni assegnate e 19 casi aperti), il presidente della Athletics Kenya Barnabas Korir è arrivato ad affermare:
«In questo momento siamo in terapia intensiva».
Ad oggi, lo stanziamento di cifre milionarie nella lotta al doping (25 milioni di dollari da spalmare in un arco di cinque anni) supporta una lotta senza quartiere, con oltre 2000 test nel solo 2023: un numero che - promette l’ADAK - è destinato a triplicare. L’impossibilità di fermare l’emorragia nonostante gli sforzi dell’ADAK, del ministero dello sport (dal 2022 presieduto dal battagliero Ababu Namwamba) e del supporto della neonata Athletics Integrity Unit (AIU) - un organo di monitoraggio fondato nel 2017, indipendente dalla World Athletics, che ha lo scopo di sorvegliare sulla liceità dell’operato degli sportivi in ambito internazionale - hanno portato alcuni a dire che «la spirale dei nuovi casi è una presa in giro agli sforzi collettivi».
Altri giudizi non sono così pessimisti. Durante una visita in Kenya nel 2023, Brett Clothier, presidente dell’AIU, sembra decisamente più rassicurante nei toni:
«più test condotti vuole quasi sicuramente dire più positività, ma non necessariamente più doping; è un passaggio doloroso ma fondamentale per restaurare l’immagine del Paese»
Sempre nel 2023, con una parte del contributo milionario stanziato dal governo keniano per la lotta al doping, l’ADAK ha stabilito un’importantissima partnership con una delle leghe sportive più importanti al Mondo, la Premier League Inglese. La partnership ha portato alla costruzione di un laboratorio di ultima generazione, il KEMRI Sports Science Research Centre, a Eldoret, la Città dei Campioni (patria di Eliud Kipchoge), il luogo al Mondo con la più alta concentrazione di runner di lunga distanza di elité. Questo centro è il più importante laboratorio anti-doping dell’Africa Orientale: l’expertise della rete di medici della Premier League dovrebbe fungere da garante per test più sicuri, rapidi, capillari e precisi, proprio in quel luogo dove si addensa il numero più elevato di podisti professionisti dell’intero Paese (e del Mondo).
Parte II. «Perché corri?»
Perché il problema del doping è così difficile da arginare, specie in un Paese naturalmente dotato di assoluti prodigi genetici del podismo di lunga distanza?
Per rispondere a questa domanda facciamo una cosa che non si dovrebbe fare: un’altra domanda. Suggerisco di partire dalla stessa che nel 2016 il giornalista britannico Ade Adepitan ha posto all’atleta keniano, Julius Kiprono Tarus. Adepitan si trova nel Paese per investigare il problema del doping: la sua indagine ha prodotto per Unreported World un breve documentario dal titolo The Betrayal of Kenya’s Athletes (uscito sull’emittente britannica Channel4).
«Perché corri? Cosa amate del fatto di correre così tanto?»
Eccoci qui, era davvero così semplice. Soldi.
Il caso di Julius Kiprono Tarus è emblematico: è un atleta estremamente dotato, di ottime speranze (già nel 2016, a 25 anni, gestisce volumi da oltre 200 chilometri settimanali, e diventerà un maratoneta da sub 2.08); ma è anche un atleta povero. All’inizio della sua carriera può permettersi un pasto al giorno; a differenza dei top runner non può concedersi di vivere una vita da professionista (massimizzando allenamento, nutrizione, riposo), e deve aggiungere ore di lavoro nei campi alla sua routine. Mica cose come avere un orto per hobby, si parla di vero lavoro fisico: che chiaramente intacca un elemento centrale come il recupero, pilastro centrale della performance. (Spoiler: Julius Kiprono Tarus non fa e non ha mai fatto uso di sostanze).
Nella sua situazione ci sono tanti giovani atleti che vedono nella corsa, e nei contratti milionari di Kipchoge - e prima di lui di Paul Tergat - una possibilità di scappare dalla povertà. Il doping diventa una scorciatoia non tanto per fare il Record del Mondo, né per ingannare per il gusto di vincere, ma per uscire da un’esistenza miserabile. I premi per i vincitori di gare tutto sommato modeste in Europa e negli Stati Uniti garantiscono introiti significativi per il Kenya. Intascare queste somme è un primo passo per l’emancipazione: permette di attirare coach più preparati e di concedersi un’esistenza più simile a quella che dovrebbe condurre un atleta, al fine di partecipare a più gare, vincerne qualcuna, richiamare qualche sponsor e permettere alla propria famiglia di uscire dalle grinfie della miseria. Qui c’è il problema: l’eccellenza non è per tutti - ci ha tenuto anche Nike a ricordarcelo con la sua ultima (discussa) campagna per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il dramma di questo assunto iper-performativo è che per i giovani atleti keniani i termini della questione non sono la vittoria e la sconfitta: ma la possibilità o meno di vivere una vita dignitosa, se non la cruda sussistenza, con la corsa che diventa una specie di Squid Game per la sopravvivenza.
Mentre si dopano per cercare di guadagnarsi da vivere, questi giovani - spesso e volentieri privi di qualsiasi tipo di educazione di base - non sanno dei rischi per la salute a cui vanno incontro, né si preoccupano del duro stigma internazionale nei confronti del proprio Paese, né tantomeno trovano nel doping un mezzo moralmente sbagliato per il raggiungimento di un’esistenza migliore.
Quanto è facile doparsi?
La cosa che stupisce guardando il documentario di Ade Adepitan è la facilità con cui per gli atleti è possibile reperire enhancers delle performance - il preferito per gli atleti di endurance è sempre lo stesso: l’EPO, una sostanza utilizzata per il trattamento di gravi patologie renali, che tra i propri effetti favorisce la produzione di globuli rossi essenziali per il trasporto dell’ossigeno ai tessuti; gli effetti di lungo termine dell’EPO sulla salute sono infausti. Un utilizzo prolungato aumenta la densità sanguigna e massimizza, tra le altre cose, le possibilità di attacchi di cuore e di ictus.
Nel giro di due visite e di un check-up sommario dei valori del sangue la sostanza è a portata dell’atleta. Dietro alla distribuzione delle sostanze dopanti c’è un reticolo fittissimo di medici e professionisti sanitari corrotti - armati dalla criminalità organizzata - che operano nella consapevolezza di avere a che fare con un pool ampissimo di professionisti, con opportunità di profitto infinite. A buttare benzina sul fuoco è il grande gioco di allenatori e manager, attratti al pari degli atleti dai guadagni di questo Far West senza leggi e senza sceriffi.
Come riportato da Brett Clothier dell’AIU, la benedizione naturale del Kenya, con la sua densità di atleti di altissimo profilo, è anche la sua condanna. Il numero e la qualità dei podisti keniani permetterebbe
«al 100esimo miglior maratoneta del Paese di andarsene in giro per il Mondo a fare ottimi soldi da professionista. Ciò porta un sacco di sfide per il programma nazionale anti-doping, perché nel resto delle Nazioni il centesimo miglior atleta in qualsiasi disciplina deve portare avanti un lavoro al supermercato per guadagnarsi da vivere, non ha incentivi a doparsi e non ci aspettiamo che le agenzie anti-doping lo testino» (da un articolo di BBC).
Sempre Clothier rimarca il fatto che il problema con la profondità del field di atleti di elité keniani sta nel fatto che monitorare solo i top mondiali della piramide è assolutamente insufficiente.
«In passato abbiamo testato solo il tetto della piramide degli atleti, mentre la base non è stata soggetta a misure come i testig out-of-competition. La piramide è di centinaia, migliaia di atleti. Anche se stiamo controllando quelli al top, e stiamo smascherando gli imbroglioni, per la pressione di coloro che sono ai livelli inferiori della piramide (non testati fuori dalle competizioni) anche gli atleti di punta continuano a prendersi rischi per cercare di rimanere in alto» (stesso intervento di sopra)
Possiamo solo immaginare quanto possa essere frustrante l’idea di dover eccellere in un Paese, come il Kenya, con una barriera all’ingresso per il professionismo altissima, dove la densità di giovani atleti che in potenza potrebbero essere capaci di un Record del Mondo su una lunga distanza è impareggiabile. È in questo interstizio che entra in gioco il doping: anche un atleta pulito come Julius Kiprono Tarus ammette candidamente di essere stato tentato dalle sirene del doping. E come avrebbe potuto non esserlo? Come può un atleta sano andare a competere serenamente per un posto nella squadra nazionale con la consapevolezza che chi gli sta un metro avanti potrebbe essere stato impunemente ammesso ai try-out senza il minimo controllo?
Come intervenire? L’importanza di educare
Oltre che al livello pratico dei controlli, le parti in gioco hanno chiesto ad atleti e figure pubbliche di mettere la faccia contro il doping. Tra i più duri inquisitori del doping in Kenya c’è ovviamente Wesley Korir: in qualità di figura politica, oltre che ex-sportivo, la sua linea è quella del pugno di ferro. Korir chiede una severa legislazione volta a criminalizzare il doping. Lo rimarca, ad esempio, in un’intervista per Al-Jazeera English del 2015, in cui parla senza mezzi termini di galera:
Nel frattempo, Korir è portavoce di un’importante iniziativa volta ad aumentare l’educazione dei giovani atleti sul doping e sui suoi potenziali rischi per la salute. Parte di quei famosi 25 milioni di dollari stanziati dal governo sono destinati all’educazione. Non si tratta solo di doping, ma anche di un problema più radicale: Korir vuole intervenire alla base, rappresentata dalla pressoché totale mancanza di basilari nozioni di disciplina finanziaria nei giovani atleti keniani - se ne parla in questa puntata del podcast Daily Africa di BBC, incentrata sulla morte di Kelvin Kiptum (analizzando le zone grigie dell’incidente d’auto nel quale l’atleta ha perso la vita insieme al suo allenatore).
«La chiave per la risoluzione del problema è la mentorship… Quando sei un atleta devi essere disciplinato. Abbiamo bisogno di più mentori».
È la stessa conclusione a cui è arrivato Eliud Kipchoge, tra i più accaniti detrattori del doping in Kenya. In una recente e lunga intervista rilasciata al media center delle Olimpiadi dopo il pesante smacco di Parigi 2024, l’affondo di Kipchoge contro i giovani atleti del suo Paese è durissimo.
«Manchiamo di morale! Ci mancano mentori, persone che ci mostrino come si debba fare. La maggior parte della persone parla di soldi. Ci mancano leggende dello sport, perché quello che abbiamo oggi sono un 80/90% di atleti che non vuole altro che denaro per costruirsi una grande casa, comprarsi una grossa auto e godersi la vita. Dovrebbe trattarsi di diventare una leggenda, correre, rompere record, e inseguire una vita lunga e sana.
Ma Kipchoge non punta il dito solo contro gli atleti: al centro delle sue numerose catilinarie contro il doping c’è il sistema dei coach e dei manager.
«Tanti di quelli che si occupano di questi atleti mancano di educazione. Non trattano lo sport come una professione, ma come un business, un palcoscenico dove prendi i soldi e scappi»
Possiamo pensare che sia facile per Kipchoge parlare dall’alto del suo status, della sua fortuna e dei contratti con i suoi sponsor: potremmo essere maliziosi, e guardarlo con lo stesso rotolamento di occhi con cui guardiamo uno di quei milionari che a favore di camera cianciano di quanto i soldi non facciano la felicità. Però Kipchoge alle parole ha fatto seguire i fatti, e l’educazione di cui tanto parla nei suoi proclami contro il doping: la sua fondazione ha la missione di portare una biblioteca in ogni villaggio del Kenya, e le prime sono già state costruite.
Conclusione. È solo questione di tempo?
Ciò che spero di aver fatto in questa puntata, lungi dal giustificare comportamenti lesivi per la salute, nonché sportivamente scorretti, è quello che Marc Bloch definiva uno dei noccioli del Mestiere di Storico: cercare di comprendere, invece che farsi ingolosire dalla «mania del giudizio». In alcuni contesti delicati e specifici il manicheismo con cui piantiamo i paletti che definiscono cosa sia assolutamente giusto e sbagliato traballano, pur non venendo completamente meno; oppure, semplicemente si spostano. E così a essere sbagliato non è più solo il gesto, e deprecabile non è chi lo compie; in una visione di più ampio respiro a essere esecrabili sono le cause che portano al gesto. Il famoso sistema, che finisce sempre per fregarci tutti con le sue lusinghe - a ognuno le sue, nessuno escluso.
È solo questione di tempo? Finché le giovani generazioni di atleti keniani vivranno nell’illusione che il gioco possa valere la candela, le possibilità di eradicare il problema del doping una volta per tutte sono basse. Basterà educare, istruire, portare mentori tra i giovani sportivi e non? Le risposte semplici non esistono mai, figuriamoci stavolta. Cominciare con il creare percorsi di accesso a una vita dignitosa attraverso l’istruzione e l’educazione non può suonare come un’opzione sbagliata.
🏃🏻♂️ Ti è piaciuta A cosa penso quando corro? Come puoi sostenere il progetto
Se non lo hai ancora fatto, iscriviti alla Newsletter: ogni iscrizione è importante, mi motiva a credere in questo progetto.
Iscriviti ad A cosa penso quando corro?
Condividi A cosa penso quando corro? con amici, parenti, contatti, su Instagram, Twitter, Facebook, in un balletto su TikTok. Vedi tu!
Il Podcast Storie di Corsa: lo ascolti qui
Anche un like o un commento alla puntata sono utili!
Il mio profilo Instagram: @ban.zo_
Il mio profilo Strava: Lorenzo Bandini
Se questa puntata ti è piaciuta e ti va di sostenere questo progetto, sostieni A cosa penso quando corro? letteralmente al prezzo di un caffè al bar.